La storia di Maria, colpita da SLA e di sua figlia Marianna, utenti del progetto “Resilienza a domicilio” – raccolta da Raffaella Arnesano.
—
Raggiunsi mamma Maria alla morte di mio padre e mi accorsi che il tono della sua voce era diverso; per gli altri quel tono era dettato dal lutto ma, dentro di me, un piccolo campanello di allarme mi spingeva a indagare per chiarire cosa le stesse accadendo.
La diagnosi arrivò dopo un anno e mezzo dai primi sintomi e confermò i miei sospetti: si trattava di qualcosa di serio, qualcosa da affrontare unite, così accolsi la mamma nella mia casa che, ben presto, si trasformò in altro, il luogo della cura.
Un piccolo ospedale con il persone di assistenza che imparai presto ad apprezzare. Certo, mi mancava il mondo precedente fatto dei mie ritmi e interessi, di cose al loro posto, ma dovevo accogliere tutto fino in fondo, per umanità nella malattia che, quando arriva, colpisce duro.
Mamma Maria è sempre stata una donna realistica e quando, in tempi non sospetti, si parlava di fine vita, ribadiva sempre l’importanza di poter scegliere quanto e come convivere con i limiti. Dunque il suo rifiuto alla tracheotomia non mi stupì: il mio ruolo era di rispettare la sua decisione e di fare del mio meglio per contenerne l’impatto concreto ed emotivo.
È l’accompagnamento in dignità, per molti anni il mio lavoro da psiconcologa ospedaliera.
Inaspettatamente, dopo una notte di ampia riflessione, mamma Maria mi comunicò con voce debole e incerta che voleva sottoporsi all’intervento, voleva provare ad andare avanti. Nei tre anni successivi mai si pentì della scelta; arrivò a festeggiare il suo 80esimo compleanno definendolo il più bello della sua vita.
La SLA salda malato e caregiver in una interdipendenza stretta, ancor più cogente nel mio caso perché unico familiare in regime h24 e perché psicologa, tanto da vedere esclusa tale figura terapeutica nel PAI, il Piano di Assistenza Integrata, “tanto non ce n’è bisogno, c’è la figlia“…sì, ma chi si occupa della mia tenuta emotiva e usura psicologica? Ho continuato a coltivare la mia nicchia salvavita scrivendo storie e romanzi, ho continuato a essere figlia, ho intessuto relazioni efficaci con il personale giovane assegnato, tutto motivato e capace, anche i molti alle prime esperienze domiciliari.
Perché la cura alla persona con malattia cronica degenerativa di III livello è, su tutto e prima di tutto, relazione di condivisione, ascolto, empatia e rispetto delle quotidianità che si assottigliano sempre più sino a ridursi a uno spicchio di stanza e a un corpo immobile. La sindrome locked-in mentre nel resto del mondo imperversava il lock-down.
E fu la fine di abbracci, giochi, carezze e sorrisi aperti, tutto imprigionato e nascosto da mascherine, visiere, tute e guanti.
E fu anche la fine della familiarità consolidata per l’insensato turn over del personale.
Tutto troppo per i livelli di qualità di vita fissati da mamma Maria per proseguire.
Decise di dissentire, di sottrarsi al furto della relazionalità che cura e dello scambio umano che sostiene.

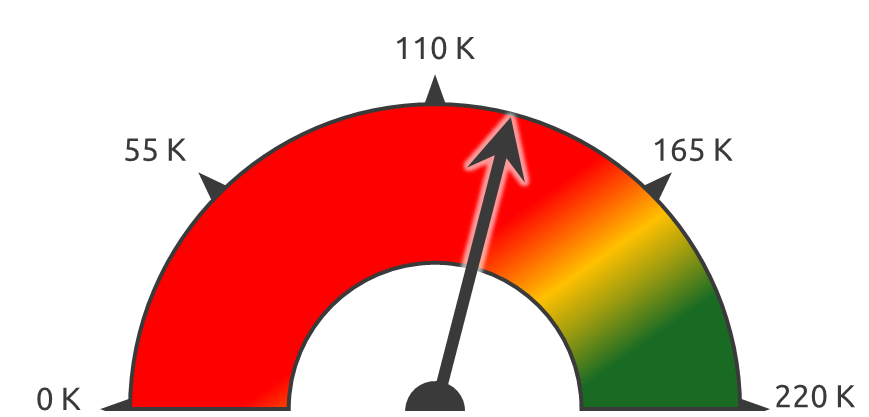










Scrivi un commento